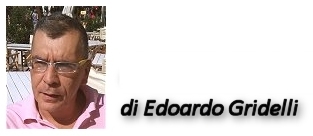
Prima di approfondire il primo fantastico concerto della ”Wiener Symphoniker“, ci pare il caso di fare una breve carellata storica su questa antica orchestra, il legame con Trieste e il valore aggiunto di questa eccezionale manifestazione ed accennare gli interpreti di questa prima serata eccezionale svoltasi a “Il Rossetti“.
Il connubio con Trieste nasce nel lontano 1902 e proprio al “Politeama Rossetti“ si esibirono per la prima volta nella nostra città. Seguirono altri 8 concerti a Trieste, segnando un’unione quasi indissolubile tra una delle massime espressioni della musica classica non solo viennese, e la nostra città.
Tant’è vero che i Wiener Symphoniker festeggiano i loro 125 anni dalla fondazione anche con una diretta della ORF, la Radio televisione Austriaca in mondo-visione, il concerto principale di domenica 13 Aprile, anche questo inserito nel trittico di spettacoli eseguiti proprio al “Il Rossetti“.
Non per nulla, vista la grande esposizione culturale, la Regione e la città hanno attirato l’attenzione mondiale su questi 4 giorni “viennesi“ di pura bravura artistica nel campo della musica e opera classica, inserendosi con gioia in un logico contesto di unici contatti inter nazione, e formando un evidente prolungamento anche con altre manifestazioni come GO!2025 – Nova Gorica e Gorizia, Capitali Europee della Cultura 2025“, visto pure il programma tra la musica tedesca, danubiana, e italiana, a sottolineare un messaggio di unità e amicizia.

Sta di fatto che lo stesso Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella ha onorato i “Wiener Symphoniker“ e il “Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia Il Rossetti“, conferendo al Festival “Primavera da Vienna 2025 a Trieste” la “MEDAGLIA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA“ che ha entusiasmato il già euforico per questi quattro giorni triestini, il Sovraintendente dei ”Wiener Symphoniker“ Jan Nast.
Lo stesso Presidente Federale della Repubblica Austriaca ha voluto sottolineare l’importanza di Trieste della sua cultura, vicinanza e ponte tra l’est e ovest dell’Europa, citando anche anche Saba e Yojce, quale città dove gli scambi culturali e di popoli è sempre stata una culla., rimarcando quale città ideale per questo Festival che è un ponte e unione di paesi sotto la bandiera europea, che dà forma e sostanza anche e soprattutto con la musica, che è universale, partendo dalle diversità degli Stati, fino a un’unione ideale dei loro popoli, così come il Festival fa: da Verdi a Wagner, così diversi nelle loro composizioni ma uniti nella lotta per le democrazie e libertà dei loro paesi.
“C’è aria di festa, si sente la musica nelle strade, c’è aria di primavera a Trieste” ha dichiarato il rieletto Presidente del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia Francesco Granbassi , “Una primavera che arriva gioiosamente da Vienna, portata dai Wiener Symphoniker”. Il comunicato stampa de “Il Rossetti” ci rammenta “ che è stato il primo teatro in cui i Wiener Symphoniker si esibirono fuori dall’ Austria, diretti da Ferdinand Löwe. Era il 4 aprile 1902 e Trieste faceva ancora parte dell’ Impero Austro-Ungarico, ma fu la prima città italiana ad ospitare un loro concerto”
Possiamo definirlo un evento storico per la nostra città, la nostra Regione e per “Il Rossetti“, ma non solo, per tutti i triestini e visitatori che hanno goduto dei vari concertini gratuiti presentati ieri tra cui il primo, quello in Piazza dell’Unità d’Italia con una fanfara appositamente composta per Trieste.

La ”Wiener Symphoniker” (Sinfonica di Vienna) è una delle orchestre più prestigiose d’Europa e rappresenta un pilastro della vita musicale austriaca accanto ai Wiener Philharmoniker. Fondata nel 1900 da Ferdinand Löwe, staccandosi dell’Associazione dei Concerti di Vienna, i “Wiener Concert – Verein”, lo scopo iniziale era quello di rendere accessibile la musica sinfonica anche ai cittadini meno abbienti di Vienna. Alla fine della Prima Guerra mondiale, assunse il nome attuale: “Wiener Symphoniker” ed è stata parte attiva della rinascita musicale dell’Austria nel secondo dopoguerra, contribuendo alla promozione di opere contemporanee e del repertorio classico. Luogo d’elezione della musica classica viennese, la “ Konzerthaus” è la sua sede principale, “residente” del Teatro dell’Opera di Bregenz, dove si svolge il celebre “Festival sull’Acqua”. Oggi, ha una forte vocazione educativa e sociale, con progetti per i giovani, concerti nelle scuole e iniziative inclusive e collabora anche con artisti crossover e jazz, rompendo i confini del repertorio classico. I Wiener Symphoniker sono un punto cardine della discografia nella musica classica e la critica internazionale l’ha sempre elogiata per le registrazioni di altissima estetica musicale e perfezione stilistica con case musicali quali la Deutsche Grammophon e la Sony Record. Infatti ha ricevuto l’“Echo Klassik, Diapason d’Or”, e altri riconoscimenti per: il ciclo delle sinfonie di Beethoven e Bruckner e le registrazioni operistiche come il “Fidelio” di Beethoven o “Tristano e Isotta” di Wagner”.Spesso è selezionata per tour internazionali in Asia, America ed Europa, come ambasciatrice della cultura viennese.
La Wiener Symphoniker può vantare di aver avuto i tra i più grandi direttori d’orchestra sin dall’inizio della sua avventura musicale: Wilhelm Furtwängler, Herbert von Karajan (1948–1960) che cooperò al rilancio dell’orchestra nel secondo dopoguerra, Wolfgang Sawallisch (1960–1970), Carlo Maria Giulini, Georges Prêtre, Vladimir Fedoseyev, Rafael Frühbeck de Burgo, per arrivare ai giorni nostri con Philippe Jordan (2014–2021): magnifico interprete delle opere di Wagner e il ciclo su Mahler, Andrés Orozco-Estrada (dal 2021): direttore colombiano-austriaco, ammirato per la sua energia e musicalità.fino a Petr Popelka, l’attuale direttore residente, di cui parleremo poi. Tra i solisti di maggior spicco possiamo annoverare tra gli altri Lang Lang, Hilary Hahn, Anne-Sophie Mutter.
La stessa Wiener Symphoniker può vantarsi di essersi imposta come una delle più celebri orchestre di “prima esecuzione europea, eseguendo “in prima” pietre miliari della storia della musica del Novecento fra cui la Sinfonia nr. 9 di Anton Bruckner, il Concerto per la mano sinistra di Maurice Ravel fino ad arrivare a opere di compositori contemporanei come Maria Staud, Michael Jarrell, Jörg Widmann. Da notare che fu la prima orchestra di Vienna a presentare tutte le sinfonie di Beethoven.
Il suo attuale direttore Petr Popelka, nato il 1° gennaio 1986 a Praga, ha studiato composizione e direzione d’orchestra al Conservatorio di Praga e successivamente alla Hochschule für Musik und Theater di Monaco.
Ai suoi esordi ha lavorato come assistente e come direttore principale in numerosi teatri d’opera e orchestre, ottenendo grande esperienza sia in ambito sinfonico che operistico.
Oggi viene considerato e visto sulla scena mondiale sinfonica ed operistica come un crescente astro nel panorama musicale internazionale. La sua carriera si è sviluppata in modo significativo negli ultimi anni, guadagnandosi un posto di rilievo nella scena musicale mondiale. Popelka ha iniziato la sua carriera musicale come violinista prima di dedicarsi alla direzione d’orchestra. Questi suoi inizi artistici hanno contribuito ad avere un approccio alla musica essenziale, consentendogli una comprensione profonda delle linee melodiche e delle dinamiche d’insieme,.prediligendo compositori romantici come Mahler e Bruckner, a compositori della sua terra natale come Janáček e Dvořák.


Popelka,è molto considerato per il suo sempre più ampio repertorio, che spazia dal classico al contemporaneo, passando anche per opere meno conosciute, a testimonianza del suo impegno ad esplorare e portare alla luce nuovi capolavori. Un direttore a tutto tondo con conoscenze ben strutturate che trasforma per rivalutare e far eseguire con forza ed esuberanza sia repertori classici che per eseguire musiche moderne: davvero un maestro nel suo campo.
Non abbiamo notato alcuna sbavatura o cambiamento orchestrale nella sua direzione di questa sera nel passare dai “balletti” delle opere di Verdi al primo tempo delle “Walchirie” di Wagner, nella seconda parte del concerto: una direzione impeccabile, supportata da cantanti di prim’ordine come il tenore Michael Spyres, (“Siegmund”), noto anche per il soprannome “ il “baritenore”. Che, grazie alla sua ampia estensione vocale e alla sua straordinaria versatilità gli permette di interpretare ruoli sia da tenore che da baritono. Spyres ha un vasto repertorio che spazia da “Mitridate, Re di Ponto” di Mozart, al “Guilliemo Tell” e “La donna del lago” di Rossini, dalla “La Damnation de Faust” di Berlioz a “Les Contes d’Hoffmann” di Offenbach.
Questa sera ci ha deliziati con una interpretazione di “Siegmund” di grande rilievo e potenza sonora impeccabile. Accanto a lui, la soprano Sarah Wegener (“Sieglinde “) la cui formazione musicale è di altissimo livello: ha studiato contrabbasso a Stoccarda, per poi dedicarsi al canto sotto la guida del Professor Bernhard Jaeger-Böhm. Ha perfezionato la sua tecnica partecipando a masterclass con Dame Gwyneth Jones e Renée Morloc. Tra le sue collaborazioni può vantare quella con il compositore Georg Friedrich Haas, interpretando ruoli principali come Nadja nella sua opera “Bluthaus”, per la quale è stata nominata “Sängerin des Jahres” (Soprano dell’Anno) dalla rivista Opernwelt nel 2011. Grazie al suo ampio repertorio: dalle opere di Strauss a Mahler, ha interpretato composizioni di Schumann, Dvořák e Schönberg, dimostrando una notevole capacità di adattamento a diversi stili musicali, tanto che ha debuttato nel ruolo di Sieglinde in “La Walkiria” di Wagner con l’Orchestra del Festival di Dresda, ottenendo elogi per la sua performance, cosa che facciamo anche noi per lo stesso ruolo interpretato questa sera,cosa che vale altrettanto per il basso tedesco di fama internazionale Georg Zeppenfeld già noto per le sue interpretazioni di ruoli wagneriani di cui stasera ne ha dato la riprova: un interprete di ruoli di grande profondità emotiva e tecnica, consolidando la sua posizione come uno dei bassi più eclettici e rispettati nel panorama operistico internazionale.
I saluti iniziali al “Il Rossetti” – presenti il Console Generale d’Austria e quello italiano, diverse autorità cittadine e militari tra cui il comandante provinciale dei Carabinieri, Colonnello Migliozzi – precedenti al Primo Concerto del Festival sono stati tenuti dal Primo Cittadino di Trieste, il Sindaco Roberto Di Piazza che ha rimarcato la vicinanza secolare di Trieste a Vienna, e quella tradizione austro ungarica che comunque è ancora viva in una città che è ancora aperta e vivace anche nella cultura e nella musica anche a questa influenza “viennese”.
Ha preso poi la parola l’Assessore alla cultura e scienze austriaca Veronica Kaup-Hasler, che riprendendo con enfasi anche le parole del suo Presidente della Repubblica ha voluto portare i saluti anche del Sindaco di Vienna e Governatore dello Stato di Vienna (essendo un Land), Michael Ludwig.
I° CONCERTO DEL FESTIVAL “PRIMAVERA DA VIENNA 2025 A TRIESTE”
NEL CENTOVENTICINQUESTIMO ANNO DALLA NASCITA DELLA “WIENER SYMPHONIKER”
TEATRO STABILE DEL FVG “IL ROSSETTI”
WIENER SYMPHONIKER
PETR POPELKA direttore
MICHAEL SPYRES Siegmund
SARAH WEGENER Sieglinde
GEORG ZEPPENFELD Hunding
PRIMO TEMPO
FANFARA PER OTTONI E TIMPANI IN ONORE DI TRIESTE
(scritta appositamente per questa occasione eccezionale di fratellanza e unione tra Vienna e Trieste)
GIUSEPPE VERDI
MUSICA PER BALLETTO DAL III ATTO DELL’OPERA “MACBETH”
Ballo I: Allegro vivacissimo
Ballo II: Allegro – Andante – Allegro
Ballo III: Valzer. Allegro vivacissimo
E’ una sezione orchestrale scritta per l’opera Macbeth, composta nel 1847 e poi rivisitata nel 1865 per una rappresentazione a Parigi. Questa versione parigina include la celebre musica di balletto nel terzo atto, conforme alle consuetudini dell’Opéra de Paris, dove ogni opera doveva contenere una sezione di balletto nella versione francese del 1865. I Balletti sono inseriti nel terzo atto, dell’ opera “Macbeth” durante la scena delle streghe. Anche se Verdi non era entusiasta dell’obbligo di scrivere balletti per le versioni parigine delle sue opere, ma nel caso di Macbeth si adattò, cercando comunque di integrare il balletto nella drammaturgia e ci fece un gran regalo come l’interpretazione di questa sera dove i tre balletti, grazie all’ interpretazione de “Wiener Symphoniker” e il suo Direttore Popelka, hanno esaltato le strutture armoniche e le loro armonie, dove la tonalità del terzo, il Valzer – Allegro vivacissimo in Sol maggiore è stata chiara, cantabile e luminosa. La scelta di questa tonalità unita al ritmo ternario del valzer (3/4) e al tempo Allegro vivacissimo crea un effetto di leggerezza e movimento continuo, che però conserva un sottofondo di magia o mistero, coerente con l’ambientazione stregonesca della scena che l’orchestra ha saputo esaltare. Il valzer è coreografico e orchestrato con grande gusto e rappresenta bene l’influenza francese sulla scrittura di Verdi in questi ballabili se a dirigerla c’è un “tale” Popelka.
GIUSEPPE VERDI
MUSICA PER BALLETTO DALL’OPERA “AIDA” (1871/80)
I Danza sacra delle sacerdotesse (Atto I, Scena II)
II Danza di piccoli schiavi mori (Atto II, Scena I)
III Ballabile (Atto II, Scena II)
La perfezione dell’orchestra nell’eseguire “La Danza delle Sacerdotesse” in Si bemolle maggiore, tonalità calda e solenne, ha evocato un senso di maestosità calma, sacra e solennità religiosa. La musica ha avuto il suo andamento lento e rituale, con un senso ipnotico e statico, in linea con il carattere sacro e cerimoniale della scena. E l’orchestrazione è stata delicata e rarefatta, dominata da legni e arpe, che hanno contribuito a un’atmosfera eterea e spirituale.
Il Ballabile dell’Atto II, Scena II dell’opera è stato il fulcro spettacolare dei 3 balletti e la grande scena musicale in Si bemolle maggiore che è una tonalità solenne e brillante, spesso usata da Verdi per sottolineare trionfi, cerimonie e solennità regale che prelude alla trionfale accoglienza dell’esercito egiziano vittorioso, noto anche come la “Marcia trionfale” che è stata valorizzata appieno con una orchestrazione ricchissima: ottoni, percussioni, legni, con un uso teatrale dei timbri che hanno creato un’atmosfera esotica e fastosa, tipica dell’ambientazione egizia rivisitata in chiave ottocentesca.
GIUSEPPE VERDI
MUSICA PER BALLETTO DAL III ATTO DELL’OPERA “DON CARLOS” (1867)
I Le ballett de la Reine “La Pérégrina”: Andante Tempo di Valzer Allegro agitato Allegro brillante Tempo di Valzer Prestissimo Allegro assai sostenuto
II Finale. Prestissimo
La Musica per balletto da «Don Carlos» di Giuseppe Verdi conosciuta anche come “Balletto del III atto” fu scritta per la versione parigina del 1867, come da tradizione dell’Opéra de Paris, dove era obbligatorio includere un balletto – ed è un articolato balletto – in sette sezioni che si svolge alla corte di Filippo II. La sequenza è sontuosa e pensata in pieno stile grand opéra, con influenze francesi. Articolato appunto in diverse sezioni dove si inizia in Mi maggiore per concludersi con la stessa tonalità. I Maestri d’orchestra questa sera hanno esaltato le sue caratteristiche musicali: tonalità brillanti e danzanti, perfette per un ambiente di corte e l’ alternanza di momenti leggeri e ariosi a sezioni più solenni.La sontuosità dei “Wiener Symphoniker” e il suo Direttore Popelka hanno accentuato l’orchestrazione elegante e l’uso raffinato di archi, fiati e legni: un’esecuzione splendida.
Appunto: Non vorremmo essere considerati scriteriati per chi ci legge, ma riascoltando questa musica per balletto, che per fortuna Verdi ha “dovuto” scrivere per la corte parigina, come accennato sopra, soprattutto per il “Macbeth“,vi è un romanticismo diverso dal solito “verdiano“, quasi un percorso che segue di poco il primo romanticismo antesiniano e in parte realizzato da Beethoven, ma lo supera, includendo anche un’aria folkloristica di profumo čajkovskijano e aggiungendo contrappunti, rincorse di ottoni e legni, tipicamente beethoveniani, come nel IV° Movimento della VII° sinfonia e pensando anche alla colossale Messa da Requiem verdiana, ci domandiamo e chiediamo scusa, se Verdi avesse avuto meno passione per i libretti d’opera e avesse scritto qualche sinfonia, non solo quelle sulle sue opere, questi sarebbero stati dei capolavori solo paragonabili a quelli di Beethoven?
SECONDO TEMPO
RICHARD WAGNER
Primo atto de “La Valchiria” WWV 86 B
Una grandiosa rappresentazione dei tre interpreti il tenore Michael Spyres nei panni di Siegmund, la soprano Sarah Wegener una spledida e perfetta Sieglinde e il basso Georg Zeppenfeld, un maestoso Hunding, hanno reso questo primo tempo de “La Valchiria“ unico e straordinario, del resto tutti questi cantanti sono famosi per questi ruoli nel mondo a giusta ragione, ma sentirli da vivo è tutta un’altra cosa. La “Wiener Symphoniker“ è stata di una perfezione dificilmente ascoltabile: l’opera “La Valchiria“ non ha una singola chiave musicale stabile, in quanto Wagner compone in fluss musikalischer (flusso continuo), senza numeri chiusi o arie, con modulazioni costanti che riflettono lo sviluppo drammatico e tale sviluppo è stato cadenzato, eseguito in maniera magnifica: dal Re minore nella apertura tempestosa, motivo del destino dando un’atmosfera cupa, al Mi maggiore associata all’amore di Siegmund e Sieglinde, e poi nella scena della scoperta dell’incesto, al Si minore nei momenti di tensione interiore e del dramma dell’opera fino al Do maggiore e Sol maggiore, chiavi usate per i momenti di luce e speranza, come nella rivelazione della spada.
Per chi ha potuto assistere a qesto concerto, ne serberà un scintillante ricordo; difficilmente si assistono a spettacoli di tale fattura da renderli quasi perfetti. E il contrappunto tra “verdiani“ e “wagneriani“, crediamo non sia stato troppo acceso, del resto due concezoni così diverse del melodramma e dei libretti delle opere, dove Verdi voleva accattivarsi il pubblico, farlo trascinare dalle sue musiche, mentre Wagner voleva che questi fosse rapito e protagonista delle sue opere, quasi fosse e dovesse essere un’esperienza trascendentale, fanno si che entrambi, nel loro mondo, abbiano offerto monumentali capolavori al genere umano e che questo contrappunto di idee nel progrmma di questa sera sia stato poco sentito, ma ascoltata solo la loro grandiosa genialità musicale.
L’orchestrazione e direzione di Popelka è stata di una qualità e di un livello altissimo, di molto superiore alle nostre aspettative, il risalto poi tra ottoni, fiati e legni è stato così ben caratterizzato, stigmatizzato come si deve fare, ma pochi lo fanno, che potremmo paragonarlo a un giovane Karl Bohm, del resto compito resogli facile dalla bravura di tutti i maestri della “Wiener Symphoniker“ Possiamo inoltre affermare che Popelka è un affabilissima persona, alla mano, di una cortesia unica, di quelle persone che conoscono che nell’umiltà di ascoltare e parlare con tutti si può sempre apprenere qualcosa: abbiamo avuto l’onore di scambiare alcune riflessioni musicali “alla pari“, perchè lui lo ha concesso, anche se ovviamente il divario è incolmabile tra lui e noi, Ciò lo distingue come altri, ma pochi, maestri d’orchestra conosciuti, che hanno avuto sempre quella propensione a dialogare e a considerare chi gli è di fronte una persona come lui, per fare un nome? Zubin Metha, e abbiamo detto tutto…
La “Prima Suarè Musicale“ die “Wiener Symphoniker” è stata eccezionale, con un pubblico in visibilio: aspettiamoci grandi cose nei prossimi due concerti!






